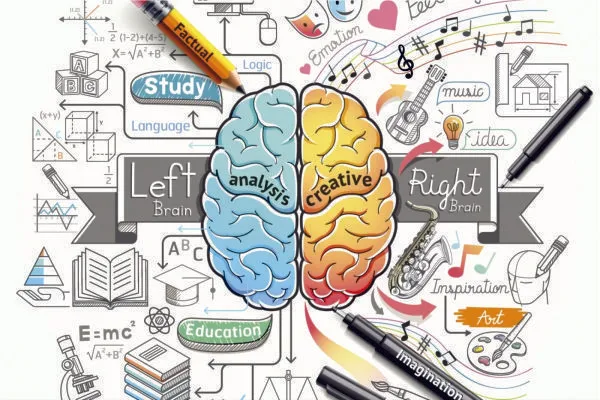
Istruzione liberale sotto pressione: il valore delle scienze umane nell’era delle competenze
L'istruzione superiore si trova oggi a un bivio cruciale a causa della rapida evoluzione tecnologica e delle pressioni del mercato del lavoro, che privilegiano competenze tecniche e specialistiche a scapito delle scienze umane e dell'approccio liberale. Questa tendenza solleva importanti interrogativi sul ruolo dell'università, tradizionalmente intesa come spazio di ricerca libera e riflessione critica. Globalizzazione e digitalizzazione spingono gli atenei a riorientare le offerte formative verso settori tecnico-professionali, con conseguente riduzione dei programmi umanistici, spesso percepiti come meno direttamente spendibili a livello occupazionale. Il professor Peter Lawler critica questo fenomeno denominato "techno-vocationalism", sottolineando come esso minacci la crescita intellettuale, etica e sociale degli studenti, impoverendo la capacità di analisi critica e contestualizzazione storica necessarie per un approfondito sviluppo umano e culturale.
Le discipline umanistiche sono sempre più spesso marginalizzate, con tagli che colpiscono indirizzi tradizionali come filosofia, storia e letteratura, favorendo invece corsi orientati a tecnologia, economia e management. Questo squilibrio nasce anche dal calo dei finanziamenti pubblici e dall’attenzione ai parametri di occupabilità immediata, penalizzando le scienze umane che tendono a offrire percorsi professionali meno lineari ma più ampi nel lungo periodo. La dialettica tra formazione professionale e istruzione liberale si fa più intensa: la prima sviluppa competenze tecniche prontamente applicabili, mentre la seconda privilegia il pensiero critico, la comunicazione e la capacità di gestire la complessità. Molti esperti e imprenditori riconoscono oggi il valore aggiunto di un mix equilibrato tra queste due visioni per affrontare con successo le sfide di un mercato dinamico e in evoluzione.
Il mutamento delle politiche governative, con sistemi di valutazione basati sulla risposta immediata al mercato e sulla capacità di attrarre fondi privati, rischia di compromettere la pluralità dei saperi e la formazione completa offerta dalle scienze umane. Pur riconoscendo la richiesta delle aziende di competenze tecniche e digitali, emergono evidenze dell’importanza cruciale delle soft skills derivanti dagli studi umanistici, quali pensiero critico, empatia, flessibilità e capacità comunicativa. Tali abilità sono fondamentali per l’innovazione e la gestione della complessità. Per preservare questo patrimonio culturale, occorrono strategie che promuovano l’interdisciplinarità, percorsi integrati fra scienze e humanities, collaborazioni con il mondo imprenditoriale e una comunicazione efficace del valore delle scienze umane. Solo in questo modo l’università potrà continuare a formare cittadini consapevoli, creativi e responsabili, in grado di rispondere in modo critico e innovativo alle sfide globali contemporanee.
